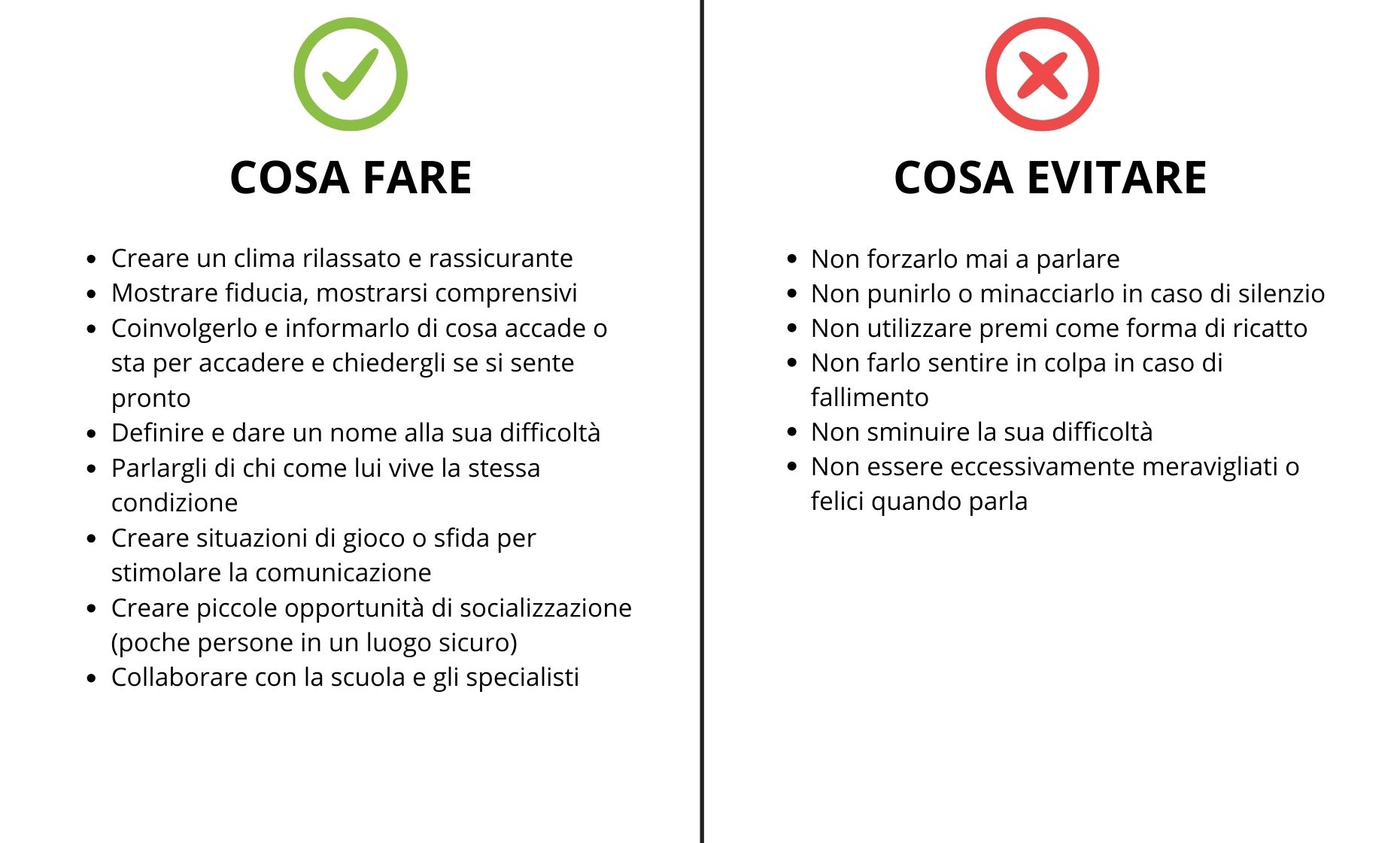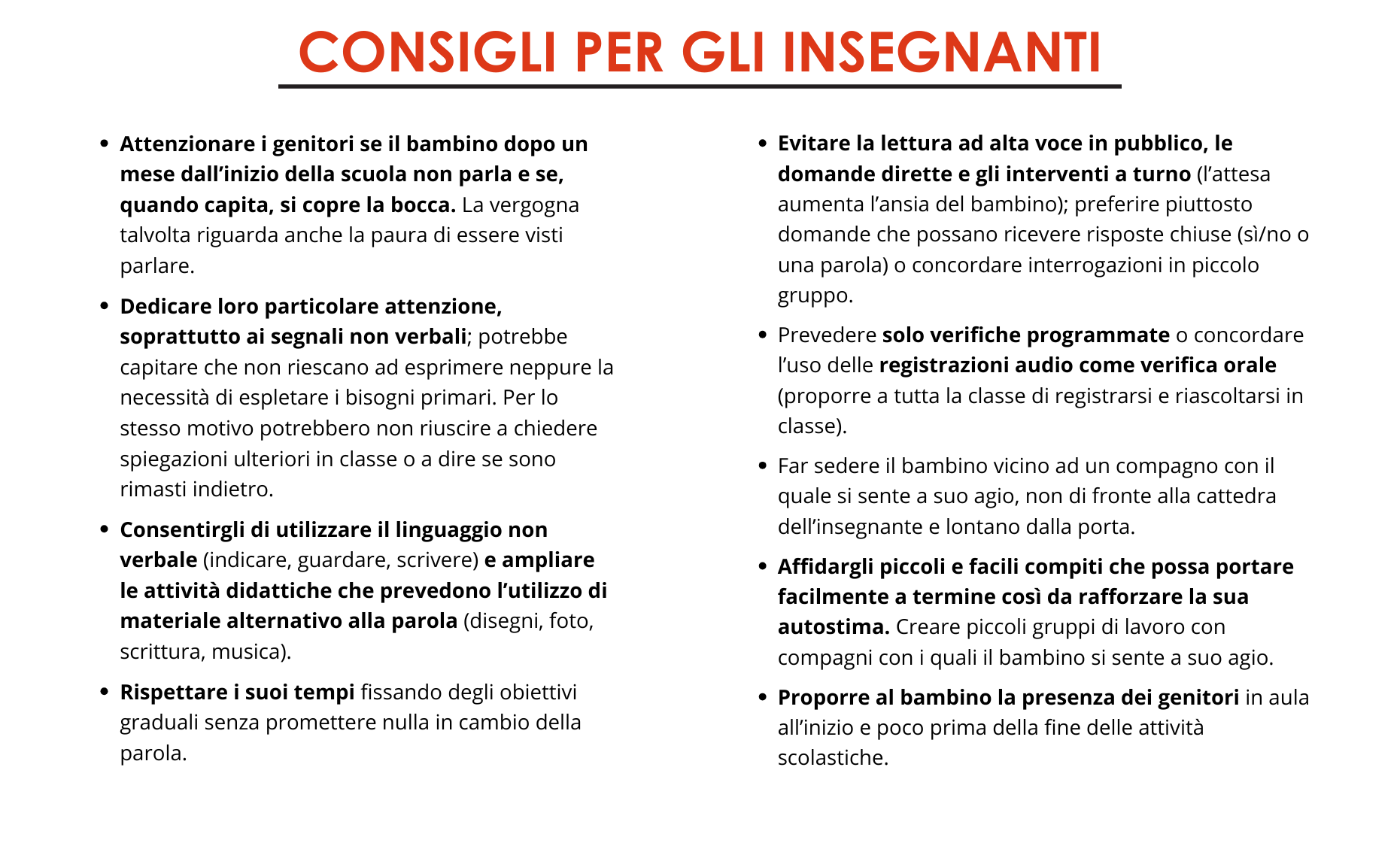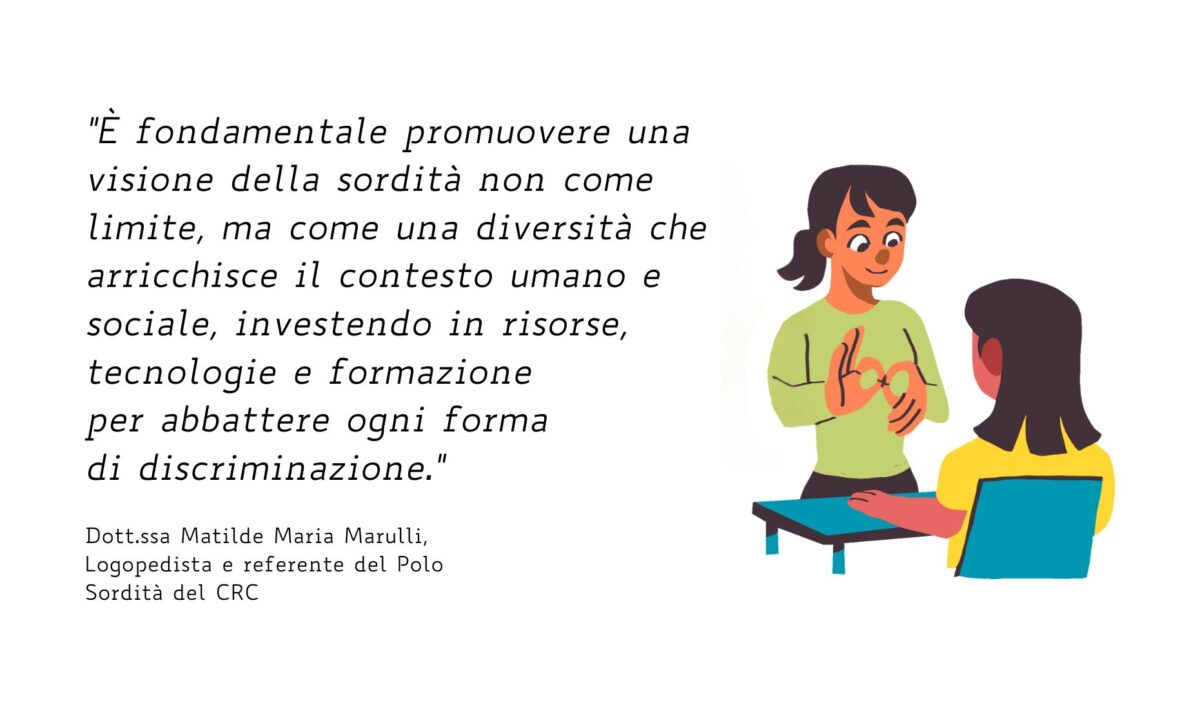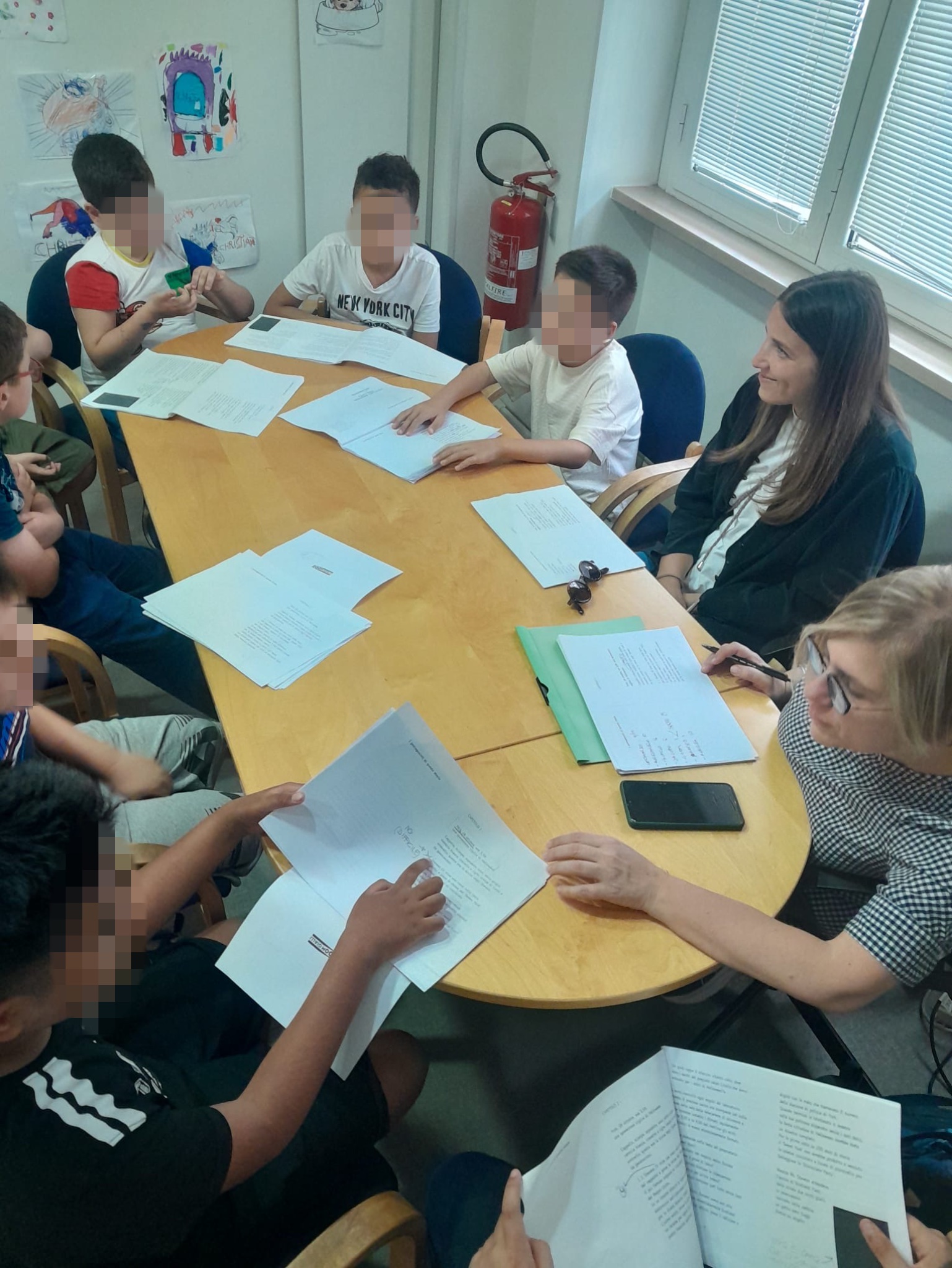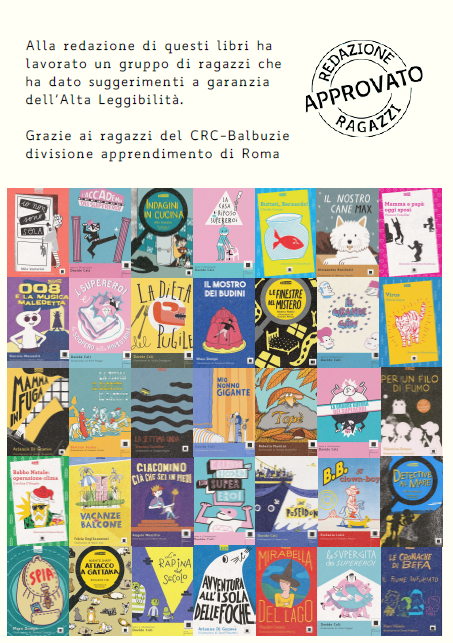Cos’è la plusdotazione o Alto Potenziale Cognitivo (APC)
La plusdotazione o alto potenziale cognitivo (APC) riguarda studenti con capacità intellettive superiori alla media, identificati da un quoziente intellettivo superiore a 130 (range medio: 85 – 115; intelligenza superiore: 116 – 129). Nonostante, in Italia, circa il 5-8% della popolazione scolastica – oltre 430 mila studenti – rientra in questa categoria il sistema scolastico non ha ancora previsto un adeguato riconoscimento o supporto.
Caratteristiche degli studenti plusdotati
I ragazzi plusdotati mostrano capacità avanzate rispetto ai coetanei dello stesso grado di scolarizzazione in ambiti logici, linguistici, matematici o artistici. In particolare presentano: memoria eccellente e vocabolario precoce (iniziano a parlare prima della media e utilizzano parole più complesse e frasi più articolate rispetto ai loro pari), insaziabile curiosità, pensiero divergente (percorsi mentali ramificati con associazioni originali), intensa sensibilità emotiva, forte senso morale e di giustizia, perfezionismo e autocritica, sviluppo cognitivo molto precoce non accompagnato da altrettanta maturità emotiva (questo squilibrio può portare a disagio).
Una normativa fino a oggi insufficiente
Fino a oggi, la normativa italiana ha preso in considerazione soprattutto DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali) con leggi e direttive specifiche. La plusdotazione, invece, è rimasta spesso nel limbo, senza un riconoscimento chiaro né interventi dedicati. Alcune scuole italiane hanno scelto di includere questi alunni tra i BES, attivando Piani Didattici Personalizzati (PDP), anche in assenza di diagnosi formali.
La nuova legge 2025: il disegno di legge n. 180
Un punto di svolta è arrivato nel 2025, con l’approvazione del disegno di legge n. 180 da parte della Commissione Cultura del Senato, che riconosce ufficialmente gli alunni plusdotati e introduce interventi concreti per il loro sostegno.
Cosa prevede il disegno di legge
Il ddl prevede:
- Criteri chiari e multidisciplinari per il riconoscimento dell’APC;
- Linee guida nazionali per l’inclusione scolastica, con attenzione alla prevenzione del disagio emotivo e relazionale;
- Un referente APC in ogni scuola, con formazione obbligatoria e continua;
- Obbligo di formazione per docenti e dirigenti scolastici;
- PDP personalizzati: possibili salti di classe, frequenza anticipata di materie, arricchimenti curriculari, tutoraggio e gruppi di studio tra pari;
- Coinvolgimento attivo delle famiglie e degli specialisti;
- Monitoraggio periodico, anche con supporto esterno;
- Integrazione dei temi legati alla plusdotazione nei percorsi universitari di area educativa e psicologica.
Perché serve una legge sulla plusdotazione
Queste misure rispondono a un’esigenza concreta: spesso i bambini plusdotati si annoiano, si isolano o mostrano scarso rendimento scolastico a causa della mancanza di stimoli adeguati. Secondo studi internazionali, fino al 17% di questi alunni può rischiare l’abbandono scolastico se non adeguatamente riconosciuto e sostenuto. L’Italia è tra i pochi Paesi europei privi di politiche sistemiche in materia, nonostante le raccomandazioni UE. Dopo l’approvazione in Commissione Cultura, il disegno di legge attende il passaggio in Aula e il parere della Commissione Bilancio.
Il riconoscimento dell’APC: una sfida complessa
Il riconoscimento dell’APC richiede strumenti diagnostici mirati, competenze interdisciplinari e attenzione al contesto emotivo e familiare, specialmente nei casi di “doppia eccezionalità”, in cui l’alto potenziale si accompagna a disturbi come DSA, ADHD o problematiche emotive. In questi casi, le difficoltà possono nascondere il talento, ostacolando diagnosi e interventi efficaci. Quando la scuola rileva un possibile APC, ha il dovere di informare la famiglia, che può attivare il percorso diagnostico con strutture specializzate.
Il ruolo centrale dei genitori
Fondamentale è anche il ruolo dei genitori, che devono:
- Osservare e ascoltare il bambino;
- Offrire stimoli e materiali adatti ai suoi interessi;
- Sostenere emotivamente e creare un ambiente sicuro;
- Collaborare con la scuola;
- Ricorrere a specialisti se necessario;
- Aiutare il figlio a gestire ansie e perfezionismo.
Un genitore consapevole può essere una risorsa fondamentale per far emergere serenamente il potenziale del bambino senza farlo sentire diverso o incompreso.